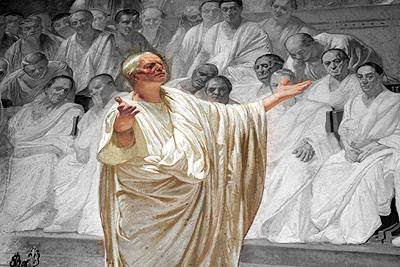Si è concluso positivamente un giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c. che ha visto impegnato lo studio.
La revocazione ex art. 395 del codice di procedura civile rappresenta uno dei mezzi di impugnazione straordinari del nostro ordinamento processuale, caratterizzato da una disciplina rigorosamente vincolata che risponde all’esigenza di bilanciare la stabilità del giudicato con l’esigenza di giustizia sostanziale in situazioni del tutto eccezionali.
L’istituto si configura come un rimedio impugnatorio a critica vincolata, esperibile esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dalla norma e limitatamente alle sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado. Come chiarito dalla giurisprudenza più recente, la revocazione risponde alla logica di consentire solo in ipotesi del tutto straordinarie ed eccezionali di mettere in discussione una decisione ormai passata in giudicato, al fine di tutelare il valore costituzionale della certezza del diritto ex art. 3 Cost. e di garantire il diritto di difesa della controparte in armonia con gli artt. 24 e 111 Cost.
I sei motivi di revocazione si distinguono tradizionalmente in due categorie fondamentali. La revocazione straordinaria, disciplinata dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395, riguarda vizi inizialmente occulti che divengono conoscibili solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza: il dolo di una delle parti in danno dell’altra, il giudizio fondato su prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza, il rinvenimento di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, e il dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato.
La revocazione ordinaria, prevista dai numeri 4 e 5, concerne invece vizi immediatamente rilevabili dalla sentenza stessa: l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa e la contrarietà ad altra precedente sentenza avente autorità di cosa giudicata tra le parti. Questi motivi, essendo per loro natura immediatamente percepibili, devono essere esperiti entro gli ordinari termini di impugnazione, operando la revocazione in rapporto di sussidiarietà con l’appello.
Particolarmente significativa è la disciplina dell’art. 396 c.p.c., che stabilisce un regime differenziato per le sentenze di primo grado per le quali è scaduto il termine per l’appello, consentendo la revocazione esclusivamente nei casi straordinari previsti dai numeri 1, 2, 3 e 6, con espressa esclusione dei motivi ordinari. Tale previsione trova giustificazione nel rilievo che i motivi di revocazione straordinaria vengono riconosciuti dalla parte soltanto a seguito della scoperta di fatti precedentemente ignorati, mentre quelli ordinari sono rilevabili fin dalla pubblicazione della sentenza.
Il procedimento revocatorio si articola in due fasi distinte: il judicium rescindens, nel quale il giudice accerta d’ufficio la sussistenza di uno dei motivi di revocazione e il nesso di causalità con la decisione impugnata, e il judicium rescissorium, caratterizzato da un ragionamento controfattuale volto a verificare la resistenza della decisione una volta sostituita l’affermazione errata con quella esatta.
La proposizione della revocazione avviene mediante citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, come stabilito dall’art. 398 c.p.c. La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti, nonché il giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti per i motivi straordinari.
I termini per la proposizione seguono una disciplina articolata: per i motivi straordinari, il termine di trenta giorni decorre dal giorno della scoperta del dolo, della falsità o del recupero dei documenti, mentre per quelli ordinari il termine segue la disciplina generale delle impugnazioni. Come precisato dall’art. 327 c.p.c., la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 non può proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
La giurisprudenza ha chiarito che ciascun motivo di revocazione presenta requisiti specifici la cui sussistenza deve essere rigorosamente accertata. Per il documento decisivo ex numero 3, è necessario che sia preesistente alla decisione impugnata e che l’impossibilità di produzione derivi da cause non imputabili alla parte. Per l’errore di fatto ex numero 4, deve sussistere un contrasto oggettivo tra la rappresentazione della realtà nella sentenza e quella negli atti processuali, senza che il fatto abbia costituito punto controverso. Per la contrarietà a precedente giudicato ex numero 5, occorre una perfetta identità tra i due giudizi quanto a soggetti e oggetto.
L’istituto trova applicazione anche in settori specialistici, come evidenziato dalla sua estensione al processo tributario, amministrativo e arbitrale, sempre nel rispetto dei principi generali che ne governano la disciplina e della sua natura di rimedio eccezionale volto a garantire giustizia sostanziale senza compromettere la stabilità del sistema giurisdizionale.
L’articolo 1116 del codice civile rappresenta una norma di chiusura del sistema della comunione ordinaria che stabilisce un importante principio di integrazione normativa tra i due principali regimi di comunione previsti dal nostro ordinamento. La disposizione, rubricata “Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria”, sancisce che “alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite”.
Questa formulazione rivela la logica sistematica sottesa al rapporto tra comunione ordinaria e comunione ereditaria nel codice civile. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’articolo 1100 del codice civile configura la disciplina della comunione ordinaria come normativa di carattere generale, applicabile “quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente”. Le norme sulla comunione ereditaria assumono invece carattere di specialità rispetto a quelle generali, trovando applicazione quando l’elemento specializzante è rappresentato dalla peculiare fattispecie costitutiva della contitolarità derivante da delazione ereditaria seguita da accettazione.
Il meccanismo di rinvio operato dall’articolo 1116 funziona secondo una logica di sussidiarietà e compatibilità. Come precisato dalla giurisprudenza di merito, le disposizioni dettate dal libro secondo del codice civile con riguardo alla divisione dell’eredità assumono carattere di specialità, dove l’elemento specializzante è dato dalla peculiare ipotesi costitutiva della situazione di contitolarità rappresentata da una fattispecie complessa che alla delazione ereditaria vede seguire l’accettazione da parte dei chiamati.
L’applicazione delle norme sulla divisione ereditaria alla comunione ordinaria non è tuttavia automatica né integrale, ma deve rispettare il limite della compatibilità con la disciplina specifica della comunione ordinaria. Questo principio trova significative applicazioni pratiche, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza in materia di retratto successorio. La Cassazione ha chiarito che il retratto successorio previsto dall’articolo 732 del codice civile non si applica nella situazione di comunione ordinaria conseguente alla congiunta attribuzione di un bene ad alcuni coeredi in sede di divisione, non potendo operare l’articolo 732 in virtù del rinvio di cui all’articolo 1116, in quanto per la comunione ordinaria vige il principio di libera disposizione della quota ai sensi dell’articolo 1103 del codice civile.
La ratio di questa esclusione risiede nella considerazione che l’istituto del retratto successorio risponde alla specifica esigenza di impedire l’intromissione di estranei nello stato di contitolarità determinato dall’apertura della successione mortis causa, finalità che non sussiste nella comunione ordinaria dove opera il principio generale della libera circolazione dei diritti. Come osservato dalla giurisprudenza, la disposizione dell’articolo 732 opera in manifesta deroga al principio della libera disponibilità del diritto di proprietà e non può trovare applicazione fuori dei casi espressamente previsti.
Diversa è invece la situazione per quanto concerne le norme procedimentali e operative della divisione. Il rinvio dell’articolo 1116 consente l’applicazione alla comunione ordinaria di principi consolidati nella divisione ereditaria, come quello relativo al regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione. La Cassazione ha precisato che nello scioglimento della comunione ereditaria, al pari di quanto accade per quella ordinaria ai sensi dell’articolo 1115 comma 3 del codice civile, il regolamento dei debiti dipendenti dai rapporti di comunione può essere realizzato attraverso il prelievo di beni dalla massa in proporzione alle rispettive quote ovvero attraverso l’incremento delle quote di concorso.
Particolarmente significativo è il principio secondo cui la comunione ereditaria, una volta sciolta mediante divisione, si trasforma in comunione ordinaria per i beni eventualmente rimasti indivisi. Come chiarito dalle Sezioni Unite, lo scioglimento della comunione ereditaria mediante divisione della maggior parte dei beni del compendio non è incompatibile con il permanere di uno stato di comunione ordinaria su singoli beni già compresi nell’asse ereditario. La comunione residuale sui beni ereditari non divisi si trasforma in comunione ordinaria, regolata dalle norme sulla comunione in generale.
La distinzione strutturale tra i due tipi di comunione emerge chiaramente dalla loro diversa configurazione ontologica. Mentre la comunione ereditaria ha natura di universitas iuris e comprende l’intero patrimonio del de cuius, la comunione ordinaria presenta una struttura atomistica, riferendosi specificamente alla “cosa comune” come evidenziato dal costante riferimento normativo a tale locuzione negli articoli 1102, 1103, 1104, 1105, 1114 e 1115 del codice civile. Come osservato dalla giurisprudenza di merito, quando i beni in comune provengono da titoli diversi, non si realizza un’unica comunione ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza.
L’applicazione dell’articolo 1116 trova inoltre rilevanza nella disciplina delle operazioni divisionali. Mentre nella comunione ordinaria la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti, nella divisione ereditaria le porzioni devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità in proporzione dell’entità di ciascuna quota. Il rinvio operato dall’articolo 1116 consente di applicare alla comunione ordinaria i principi più articolati della divisione ereditaria quando ciò risulti compatibile con la natura atomistica della prima.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l’applicazione delle norme sulla divisione ereditaria alla comunione ordinaria non può estendersi agli aspetti che contrastano con i principi fondamentali di quest’ultima. Emblematico è il caso della determinazione delle quote di partecipazione, dove la Cassazione ha precisato che nella comunione ordinaria la misura della partecipazione risulta già stabilita dalla legge secondo il principio della parità delle quote sancito dall’articolo 1101 del codice civile, rendendo superflua qualsiasi determinazione assembleare di carattere provvisorio tipica invece della gestione condominiale.
L’articolo 1116 rappresenta dunque un meccanismo di integrazione normativa che consente di colmare le lacune della disciplina della comunione ordinaria attingendo al più ricco patrimonio di norme elaborate per la comunione ereditaria, sempre nel rispetto del principio di compatibilità che impedisce l’applicazione di istituti specificamente legati alla natura successoria del rapporto. Questa tecnica legislativa riflette la consapevolezza del codificatore circa la necessità di assicurare completezza normativa alla disciplina della comunione ordinaria senza snaturarne i caratteri distintivi, realizzando un equilibrio sistematico tra specialità e generalità che caratterizza l’intera architettura del diritto civile dei beni.
Sentenza Corte di Appello di Roma n. 349/2025