La recente pronuncia del Tribunale di Roma n. 1318/2025 offre un'analisi esemplare delle problematiche connesse all'impugnazione dei testamenti olografi per falsità, delineando con chiarezza i principi giuridici e le metodologie probatorie che governano questa delicata materia del diritto successorio.
La vicenda processuale trae origine dall'impugnazione di un testamento olografo con il quale il de cuius aveva disposto un legato di 50.000 euro in favore del badante. L'erede universale, istituito con precedente testamento olografo del 27 luglio 2010, ha contestato l'autenticità del secondo testamento, sostenendone la natura apocrifa e chiedendone la declaratoria di nullità.
La peculiarità del caso risiede nella circostanza che il secondo testamento non revocava esplicitamente il precedente, limitandosi a disporre un legato che risultava perfettamente compatibile con l'istituzione ereditaria già operata. Questa configurazione ha consentito al Tribunale di affermare la legittimazione dell'attore, in quanto erede universale secondo il primo testamento non contestato.
La disciplina del testamento olografo trova il proprio fondamento nell'articolo 602 del codice civile, che stabilisce i requisiti formali essenziali: il testamento deve essere "scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore". L'autografia rappresenta dunque un elemento costitutivo imprescindibile, la cui mancanza determina nullità ai sensi dell'articolo 606 del codice civile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'impugnazione per falsità del testamento olografo si configura come domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con conseguente allocazione dell'onere probatorio in capo al soggetto che contesti l'autenticità del documento. Tale orientamento, consolidato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12307/2015, trova conferma nella recente giurisprudenza di merito, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 887/2025.
Il cuore della decisione romana risiede nell'analisi della consulenza tecnica d'ufficio; il Tribunale ha evidenziato come la metodologia seguita dalla consulente sia stata rigorosamente scientifica, articolandosi nelle fasi canoniche dell'indagine grafologica: esame del documento in verifica, analisi delle scritture comparative, fase confrontuale e formulazione delle conclusioni.
La consulente ha proceduto ad un'analisi multidimensionale del testamento contestato, esaminando il ritmo scrittorio, l'immagine grafica, l'armonia compositiva, le dimensioni dei caratteri, la pressione del tratto e tutte le caratteristiche grafiche-estetiche. Particolare rilevanza ha assunto l'analisi delle scritture di comparazione, costituite non soltanto da sottoscrizioni ma anche da pagine manoscritte, incluso il precedente testamento olografo del 2010.
L'elemento decisivo per l'accertamento della falsità è stato individuato nella peculiarità che il testamento impugnato risultava vergato in stampatello, mentre tutte le scritture comparative del de cuius utilizzavano esclusivamente il corsivo. Inoltre, la consulente ha rilevato l'assenza di fluidità nel tratto, evidenziando interruzioni, stacchi, riprese e giustapposizioni ben visibili dall'analisi microscopica e rilevabili anche dalla presenza di macchie di inchiostro generate dalle soste nella stesura dello scritto.
Un aspetto particolarmente significativo della pronuncia riguarda l'identificazione dell'assenza di fluidità nel tratto come elemento sintomatico di falsificazione. La consulente ha correttamente osservato che tali caratteristiche sono tipiche di chi scrive senza naturalezza, risultando del tutto assenti nelle scritture autografe comparative del de cuius, anche in quelle coeve o temporalmente vicine al testamento impugnato. Costituiscono infatti indizi di falsificazione la scrittura poco fluida, lenta, accurata, slegata, con pressione piatta e uniforme che non risponde all'alternanza fisiologica di chiari e scuri tipica della scrittura spontanea, la presenza di tremolii dovuti ad eccessivo controllo della penna, arresti e rallentamenti del moto grafico.
Il Tribunale di Roma ha aderito integralmente alle conclusioni della consulenza tecnica, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice di merito esaurisce l'obbligo di motivazione aderendo alle conclusioni del consulente che abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte. Tale principio, riaffermato dalla Cassazione con le sentenze n. 33742/2022 e n. 15147/2018, trova applicazione quando le conclusioni peritali risultino adeguatamente argomentate e immuni da vizi metodologici.
La declaratoria di nullità del testamento per difetto di autografia comporta conseguenze giuridiche di particolare rilevanza. In primo luogo, resta assorbita la domanda subordinata di inefficacia del legato ex articolo 654 del codice civile, che trova applicazione quando il testatore abbia lasciato una cosa particolare non presente nel patrimonio al momento della morte. La nullità del testamento determina inoltre il rigetto della domanda riconvenzionale del convenuto, diretta all'esecuzione del legato, che presuppone necessariamente la validità del testamento stesso.
La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un esempio paradigmatico dell'approccio metodologico che deve caratterizzare l'accertamento della falsità dei testamenti olografi. La pronuncia evidenzia come la consulenza tecnica grafologica, quando condotta con rigorosa metodologia scientifica, costituisca strumento probatorio privilegiato per l'accertamento dell'autografia. La decisione conferma inoltre l'importanza dell'analisi dinamica della scrittura, che deve estendersi oltre la mera similarità formale per indagare gli aspetti ritmici e motori del grafismo. L'assenza di fluidità nel tratto, le interruzioni e le giustapposizioni costituiscono elementi sintomatici di particolare rilevanza, specialmente quando contrastino con le caratteristiche grafiche costanti del presunto testatore.
Sentenza Tribunale Roma n. 1318/2025
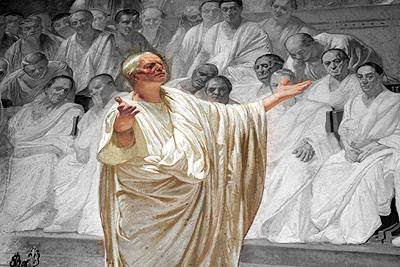
Nessun commento:
Posta un commento