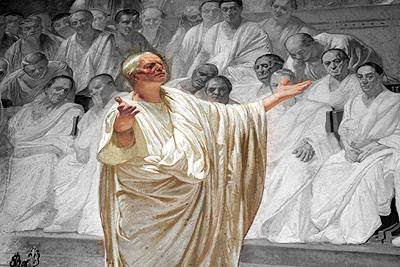La vicenda processuale trae origine da un'opposizione a precetto proposta da un coerede avverso l'intimazione di pagamento notificatagli da altro coerede. Il cuore della controversia risiede nell'eccezione sollevata dall'opponente circa la natura non esecutiva della sentenza costitutiva per i capi condannatori dipendenti; la questione si inserisce nel più ampio dibattito sulla portata dell'articolo 282 c.p.c., che stabilisce la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado.
Il Tribunale romano affronta preliminarmente la questione della corretta qualificazione dell'azione proposta dall'opponente, richiamando il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il giudice ha il potere dovere di qualificare giuridicamente l'azione, la pronuncia chiarisce la distinzione fondamentale tra opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.. La differenziazione si basa sull'oggetto delle contestazioni: quando si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, si configura l'opposizione all'esecuzione; quando invece le contestazioni riguardano le modalità con cui è stata introdotta l'esecuzione, trova applicazione l'opposizione agli atti esecutivi. Nel caso di specie, l'eccezione di inesistenza di un valido titolo esecutivo ha condotto il giudice a qualificare correttamente la domanda come opposizione all'esecuzione.
La questione centrale affrontata dalla sentenza riguarda l'applicabilità del principio di esecutività provvisoria alle sentenze costitutive. Il Tribunale richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la generale provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo grado trova un limite nelle pronunce che, per loro natura, non tollerano tale anticipazione degli effetti. La questione centrale affrontata dalla sentenza riguarda l'applicabilità del principio di esecutività provvisoria alle sentenze costitutive; il Tribunale richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la generale provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo grado trova un limite nelle pronunce che, per loro natura, non tollerano tale anticipazione degli effetti. La giurisprudenza di legittimità ha elaborato una distinzione fondamentale, cristallizzata nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 4059 del 2010, secondo cui l'esecutività provvisoria delle sentenze costitutive è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta interdipendenza con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale.
Il giudice romano osserva che l'accertamento del diritto in capo all'opposta di vedersi riconosciuto l'indennizzo spettante all'erede pretermesso dei rendimenti relativi alla gestione degli immobili caduti in successione non ha alcun rapporto di stretta interdipendenza con la parte costitutiva della pronuncia relativa alla assegnazione dei beni. Questa valutazione si fonda su una considerazione sostanziale di notevole rilevanza: l'eventuale riforma della sentenza nella sua parte costitutiva non avrebbe potuto influire sulla condanna al pagamento dei rendimenti, restando comunque dovute le somme destinate a ristorare l'erede pretermesso. Si configura, pertanto, un rapporto di mera dipendenza tra il capo costitutivo e quello condannatorio, che rende quest'ultimo immediatamente esecutivo.
La pronuncia del Tribunale di Roma in esame si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che tende a valorizzare l'autonomia sostanziale dei diversi diritti azionati, anche quando questi trovino riconoscimento in un'unica pronuncia giudiziale. L'approccio seguito dal giudice romano dimostra come l'applicazione meccanica del principio di non esecutività delle sentenze costitutive debba cedere il passo a una valutazione sostanziale del rapporto intercorrente tra i diversi capi di decisione. Particolarmente significativa appare la considerazione secondo cui il diritto dell'erede pretermesso ai rendimenti immobiliari presenta caratteri di autonomia rispetto alla divisione ereditaria propriamente detta. Tale autonomia giustifica l'immediata esecutività della relativa condanna, indipendentemente dalla stabilità della pronuncia costitutiva sull'assegnazione dei beni.
Tribunale Roma sentenza n. 13738/2023