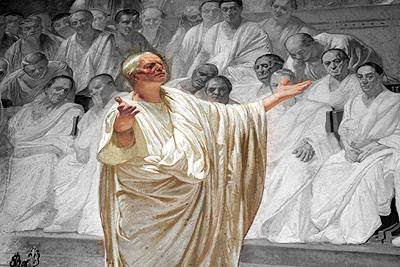La recente sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 11597/2025 offre un interessante spunto di riflessione sui doveri informativi del mediatore immobiliare e sulle conseguenze del suo inadempimento. Il caso, che ha visto l'accoglimento della domanda di restituzione della provvigione a seguito del recesso giustificato dell'acquirente, si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che delinea con crescente precisione i confini della responsabilità professionale del mediatore.
Nel caso in esame successivamente alla sottoscrizione della proposta era emersa la presenza di un'iscrizione ipotecaria sull'immobile, circostanza che non era stata comunicata al momento della sottoscrizione della proposta d'acquisto; il Giudice ha ritenuto che tale omessa comunicazione giustifica il recesso dell'acquirente, osservando che "tale iscrizione ipotecaria doveva essere posta a conoscenza dell'acquirente al momento della sottoscrizione della proposta irrevocabile".
Il fondamento normativo della responsabilità del mediatore trova la sua fonte principale nell'art. 1759 del Codice Civile, che stabilisce che "il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso". Questa disposizione, tuttavia, non può essere interpretata in modo isolato; come chiarito dalla giurisprudenza più recente, l'obbligo informativo del mediatore deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 c.c. e con la disciplina della L. n. 39 del 1989, che ha conferito natura professionale all'attività di mediazione. Ne deriva che il mediatore è tenuto ad osservare la diligenza qualificata prescritta dall'art. 1176, comma secondo, c.c., che comprende l'obbligo di comunicare non solo le circostanze a lui note, ma anche quelle conoscibili con tale diligenza professionale.
L'orientamento giurisprudenziale ha progressivamente ampliato la portata dell'obbligo informativo del mediatore. Se inizialmente si richiedeva la mera comunicazione delle circostanze effettivamente note, oggi la giurisprudenza richiede al mediatore di informare anche sulle circostanze conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale; di talché costituisce inadempimento agli obblighi informativi l'omessa comunicazione, al momento della sottoscrizione della proposta d'acquisto, dell'esistenza di abusi edilizi e vincoli che impediscono la stipula del rogito, quando tali circostanze siano già note al mediatore o risultino da documentazione in sua disponibilità. Il mediatore è, dunque, tenuto a verificare e fornire adeguate informazioni sull'immobile prima di proporre un affare come fattibile.
Sul tema relativo alle irregolarità urbanistiche dell'immobile, la Suprema Corte (Cass. sentenza del 16/07/2010 n. 16623) ha affermato che “in tema di responsabilità del mediatore, la mancata informazione del promissario acquirente sull’esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all’ immobile oggetto della promessa di vendita, della quale il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell’immobile contenuta nell’atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi, legittima il rifiuto del medesimo promissario di corrispondere la provvigione". In un altro arresto (Cass. sentenza del 16/09/2015 n. 1814) gli Ermellini hanno stabilito che “in tema di compravendita immobiliare, il mediatore che abbia fornito alla parte interessata alla conclusione dell’affare informazioni sulla regolarità urbanistica dell’immobile, omettendo di controllare la veridicità di quelle ricevute dal venditore non ha assolto l’obbligo di corretta informazione in base al criterio della media diligenza professionale, che comprende non solo l’obbligo di comunicare le circostanze note (o conoscibili secondo la comune diligenza) al professionista, ma anche il divieto di fornire quelle sulle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, sicché è responsabile per i danni sofferti dal cliente”.
La giurisprudenza richiamata richiede al mediatore immobiliare un elevato standard di diligenza professionale nell'adempimento degli obblighi informativi. La presenza di gravami o vincoli sull'immobile, anche se potenzialmente inefficaci, ovvero di abusi costituisce una circostanza che deve necessariamente essere portata a conoscenza dell'acquirente prima della sottoscrizione della proposta, pena il diritto del cliente a non corrispondere la provvigione e ad essere risarcito dei danni subiti.
Sentenza Giudice di Pace Roma n. 11597/2025